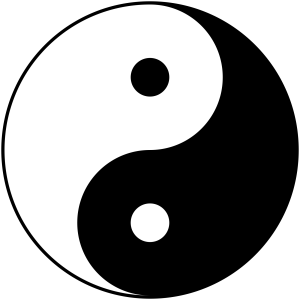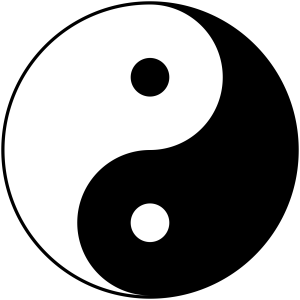Ho una salute più che decorosa. Vivo in una casa piuttosto solida. Sono imbarcata in una felice relazione sentimentale da un considerevole periodo di tempo. Da sempre lavoro con contratti parasubordinati a tempo determinato.
Al secolo, sono una precaria.
Cioè, in pratica, hai voglia a costruire con malta e calcestruzzo vari anfratti della tua esistenza, tanto poi se sei un lavoratore atipico, la tua identità sarà quello di precario.
Sono una precaria.
Il rapporto di amore e odio che ognuno di noi ha con il proprio lavoro qualche volta pende verso l’amore, qualche volta verso l’odio, ma sfido chiunque a dimostrarmi che entrambe le componenti non sono sempre presenti in misura variabile. Personalmente dentro al mio Yang lavorativo ci trovo un sacco di cose strabelle, tra cui primeggiano i miei colleghi, ma svettano pure la varietà, la libertà, l’autonomia, l’interesse mio, ma anche un po’ collettivo, l’imparzialità, la vicinanza a casa, la possibilità di tenere in piedi una famiglia e (ridete pure) la continuità (mai smesso di lavorare o di percepire lo stipendio). E’ nello Yin, chevvelodicoafà, che albergano i pochi diritti e la succitata precarietà.
E’ così, la mia generazione pare sia così, stretta dentro a dei vestiti che portiamo nostro malgrado, ammirando da lontano gli sfavillanti abiti a tempo indeterminato che hanno popolato il guardaroba dei nostri genitori e per i quali siamo disposti a fare follie. Viviamo nel mito costante del tempo indeterminato. Se un nostro coetaneo, indipendentemente da cosa abbia trovato, ci dice che l’hanno assunto a tempo indeterminato, lo guardiamo come un miracolato, ci accostiamo alla sua aura sperando di venirne in qualche modo contagiati. Nemmeno abbiamo sentito che inseminerà ippopotame ipofertili allo zoo di KualaLumpur per il resto della sua esistenza. Quel che conta è che lo farà per sempre.
Già, per sempre.
Quel che dico sempre a tutti quelli che, dopo avermi chiesto aggiornamenti sul mio lavoro, farfugliano condoglianze intorno ai miei contratti buoni per conservare il formaggio nello scomparto più basso del frigo, è che non puoi veramente mettere la “vi” dentro a tutte le caselline. Almeno faccio quello che mi piace – dico loro e dico a me- pensa tu che condanna fare un mestiere brutto per tutti i giorni della tua esistenza.
Qualche giornalista a tempo indeterminato ha definito il posto fisso un falso mito. Non saprei, a me comunque pare verosimile.
Qualche volta può persino capitare che noi precari finiamo per amarlo il nostro posto atipico, in una sindrome di Stoccolma sui generis, che ci porta sotto sotto a fregiarci di questa caratteristica, come moderni maledetti della società. Les atipiques maudits.
Qua e là ci penso e, in una specie di vertigine di folle inverosimiglianza -dall’alto di una posizione privilegiata di chi, me ne rendo perfettamente conto, un contratto serio in famiglia almeno ce l’ha- ecco lì mi viene quasi quasi da indovinare che poi se mi dovessero mai assumere a tempo indeterminato (quando?), un po’ quasi potrebbe dispiacermi, anzi potrebbe letteralmente farmi sentire una merda a confronto dei compagni di ventura ancora parasubordinati, paranoiati, parainculati.
Non so se sia colpa del tempo che viviamo o se sia tutta farina del mio sacco, ma quel che è sicuro è che sono una minus habens emotiva a tempo indeterminato.